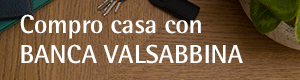Bisogna considerare poi l’eventualità dell’esistenza di altri universi dei quali noi, nel caso, conosciamo nulla.
Secondo una tradizione antica per capire la struttura del cosmo bisogna rifarsi al simbolismo arcaico della croce, il cui asse orizzontale è costituito da infiniti punti.
Ogni punto è un universo.
Di tutti questi punti, solo uno si è manifestato: quello rappresentato dallo sviluppo sull’asse verticale. Tutti gli altri appartengono al Non-manifestato.
Pertanto gli universi sono infiniti, ma noi ne conosciamo, in modo molto limitato, soltanto uno.
Quel poco che sappiamo lo dobbiamo innanzitutto a Galileo, che ha avuto il merito di inventare il metodo scientifico, un modo rivoluzionario per capire il mondo.
Egli è partito dal basso e cioè dalle osservazioni, per risalire poi a leggi universali, determinando così il definitivo tramonto della scolastica.
Tutto il contrario dei suoi predecessori le cui preoccupazioni erano di essere coerenti con verità stabilite dall’alto.
Tutte le dimostrazioni dovevano confermare tali verità: pena la scomunica o il rogo. Impossibile che potessero essere false.
All’università gli studenti sono stati costretti a studiare per secoli le corbellerie del sistema tolemaico con gli arzigogolati giri dei pianeti intorno alla terra, con i loro movimenti circolari come il deferente e l’epiciclo e con alcuni punti particolari chiamati equanti.
All’Università di Padova, Galileo aveva un collega che si chiamava Cesare Cremonini che insegnava filosofia, il quale, invitato da Galileo, si rifiutò di guardare nel telescopio il movimento dei pianeti. Perché?
Per non scombussolare lo schema di mondo che aveva in testa ed essere poi conseguentemente costretto a cambiare la sua filosofia.
Poveri studenti.
Credete voi che oggi non ci siano più Cremonini?
Ce ne sono tanti, tantissimi e sapete dove albergano? Prevalentemente nelle università.
Una delle nuove scienze, a quasi tutti ignota, di cui si è incominciato a parlare verso la fine del novecento, è quella della complessità.
Oggi, se ponete un Cremonini di fronte a un problema complesso, egli, non saprà risolverlo perché, in primo luogo, non comprende il termine “complesso”, e se glielo spiegate, non vi capisce e non vi capisce perché non conosce il linguaggio della complessità e, in secondo luogo, non ne comprende il contenuto perché non vuole guardarci dentro e ammesso che ci guardi, non è detto che veda.
Se agli studenti di scuola media, che avessero appreso i primi rudimenti di tale scienza, si chiedesse un giudizio sulla classe dirigente italiana, soprattutto politica, degli ultimi sessant’anni, direbbero senza dubbio di trovarsi di fronte a una massa di deficienti, se non di peggio e tale valutazione non sarebbe errata.
Prescindendo dal linguaggio e dalla sostanza, non c’è dubbio che esistono problemi difficili da risolvere.
Per esempio, che cosa fare quando è impossibile o troppo arduo arrivare a una soluzione analitica di un problema matematico?
O si rinuncia alla sua soluzione oppure si ricorre a tecniche di approssimazione.
Di queste ve ne sono di due tipi:
- approssimazione deterministica, via calcolo numerico
- approssimazione stocastica, via probabilistica.
La prima via è preclusa quando il problema è ampio (molte variabili) oppure molto complicato (le matematiche possono essere solo complicate, ma non complesse: il complesso è un’altra cosa, un altro campo).
Per esempio, per comporre la classifica in ordine d’importanza delle pagine web, che sono circa quaranta miliardi, bisognerebbe risolvere un sistema omogeneo di quaranta miliardi di equazioni lineari, con quaranta miliardi di incognite.
Oggi non esistono risolutori di sistemi così vasti.
Si tenta allora di percorrere la via probabilistica.
Infatti, Google, il cui motore di ricerca è usato gratuitamente da circa l’ottanta per cento degli utenti Internet, segue tale via e precisamente quella della passeggiata casuale: si tratta di una passeggiata particolare di tipo MCMC, acronimo di Markov Chain Monte Carlo, che classifica le pagine web in ordine d’importanza.
Andrej Andreevic Markov (Rjazan’ 1856 – San Pietroburgo 1922) nel 1906 formulò la dipendenza tra quantità aleatorie che oggi chiamiamo catene di Markov.
Markov scrisse di tale dipendenza a proposito di una polemica che oppose l’accademico pietroburghese a un gruppo di matematici moscoviti patrocinato da Pavel Alekseeviˇc Nekrasov e legato agli ambienti tradizionalisti della Chiesa ortodossa.
Era convinzione di questi matematici che l’esistenza di una legge statistica per le osservazioni casuali, quale quella dei grandi numeri, postulasse il libero arbitrio, e che l’espressione di questo fosse l’indipendenza stocastica tra le quantità casuali. Pertanto condizione necessaria affinché possa valere la legge dei grandi numeri è l’indipendenza stocastica.
Il lavoro del 1906, nel quale Markov dimostrava la legge dei grandi numeri per una classe di quantità casuali dipendenti, forniva la prova che i suoi antagonisti erano in errore.
Le catene di Markov, sorte per motivi teologici, hanno avuto una grande fortuna in tutti i campi della scienza.
Markov stesso, più tardi, le utilizzò in uno studio pioneristico di linguistica probabilistica, analizzando l’alternarsi di vocali e consonanti nell’Evgenií Onegin (un poema di Puškin) e in una novella di Aksakov.
L’altro elemento per realizzare la passeggiata in parola, è l’utilizzo dei numeri casuali con il metodo Monte Carlo (una tecnica inventata negli anni ’40 del ‘900, dagli scienziati del Progetto Manhattan).
I numeri casuali non sono una novità. Coloro che ne avevano bisogno, per lavori scientifici o per altri motivi, per generarli ricorrevano a metodi empirici lenti, come il lancio di dadi oppure l’estrazione dall’urna di palline numerate.
La prima tabella, contenente 40.000 numeri, fu costruita nel 1927 da un rapporto su un censimento.
Un’altra tabella di 100.000 numeri casuali fu pubblicata dalla Rand Corporation nel 1955.
Con la diffusione dei computer non furono più usate tabelle, che occupano molta memoria e richiedono un certo tempo per ricercare il numero in esse contenuto (ricordo che nei primi computer la memoria di massa era contenuta in schede perforate). Esse furono sostituite da un algoritmo che, con poche istruzioni e quindi con poca memoria, genera i numeri casuali in pochi istanti.
Il numero casuale è la nostra guida per la passeggiata.
Se decido di fare una passeggiata casuale di 1000 passi toccando i punti stabiliti dalla catena di Markov, e mi trovo al punto1, per raggiungere il punto successivo devo generare un numero casuale che m’indicherà quale sia questo secondo punto. Alla fine dei mille passi il punto che è stato visitato più volte è quello più importante.
Viene fatta una classifica dei punti in ordine di numero di visite e perciò in ordine di importanza.
I numeri casuali sono utilizzati in molte applicazioni come:
- i processi fisici quali i decadimenti radioattivi
- il rumore termico in un circuito elettronico
- i tempi di arrivo di raggi cosmici
- problemi di decisione
- la simulazione degli arrivi dei passeggeri alle stazioni ferroviarie o delle metropolitane
- la simulazione degli arrivi di autoveicoli ai caselli autostradali
- la simulazione della nascita e della morte delle cellule di esseri viventi
- la simulazione dello sviluppo o del declino della popolazione in un certo paese o territorio
- la simulazione di fenomeni naturali in genere
Eccetera.
I numeri casuali siamo noi. Noi siamo numeri casuali.
Noi, quando ci domandiamo come mai siamo qui. Noi e quei punti lassù
“tra le rossastre nubi
stormi d'uccelli neri,
com'esuli pensieri,
nel vespero migrar”
LoStraniero