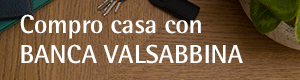.
Le argomentazioni dei dialoganti si articolano attraverso la contrapposizione credente non-credente, che trovano la loro convergenza nell'Agape o amore per il prossimo, che nelle forme laiche di chi non crede in Dio sono una naturale espressione della coscienza a perseguire il bene e per chi crede è la gloria di Dio che scende nei nostri cuori attraverso la testimonianza del Cristo e il suo amore per il prossimo.
(A tal proposito è interessante la forma scientifica di "violenza"descritta nello stesso libro da Umberto Veronesi.
Definendo la violenza come reazione a situazioni avverse e che nulla ha a che fare con forme di malattia mentale o di vantaggio evoluzionistico a favore dei più forti, perché l'evoluzione bada ai più adatti e non ai più forti, Veronesi dimostra in questo di esprimere del concetto della forza un suo momento e, dato che la forza é vir da cui deriva appunto virtù, di non aver presente che i più adatti sono appunto i più forti; ma aiuta a comprendere, sotto una luce diversa, che cosa sia la violenza.)
Scalfari dichiara di non essere un credente, ma crede, infatti scrive che lui crede nell'Essere come il caos che produce, quando esplode della sua Energia, le Forme.
"Le Forme hanno le loro leggi, i loro campi magnetici, i loro elementi chimici, che si combinano casualmente, evolvono e infine si spengono, ma la loro Energia non si distrugge".
Insomma, Scalfari, che si dice un moderno, oltre a descrivere il Dio teologico, non aggiunge nulla al concetto aristotelico di "sostanza" e "forma", che non significa che lui è un antico ma che Aristotele è un moderno che ha qualche cosa in più da dire.
Queste parole, che già portavano turbamento ad Aristotele, maestro di color che sanno, sembrano, in questo dialogo fra "moderni", non altrettanto "pericolose" e quindi non sono da utilizzare con prudenza (altra virtù).
Si tratta di comprendere che un uomo é profondo nelle sue argomentazioni se in quelle non si contraddice, dice Aristotele di Eraclito, che per lui è uomo profondo, e per questo motivo alla Sostanza o sostrato permanente e alle Forme accidentali Aristotele doveva in qualche modo rispondere altrimenti con le parole "evolvere" e "spegnersi" usate da Scalfari, con tanta disponibilità, avrebbe mostrato a se stesso di essere in contraddizione.
Infatti, pensare ad un'"Energia" perenne (=eterna) e ad una "Forma" contingente (= caduca, mortale) é contraddizione e questo Aristotele lo sapeva benissimo, cosa che a Scalfari non sembra nemmeno sfiorare, mostrando in poche righe che la sua non regge; è particolare come le persone che si rifanno al pensiero moderno, incarnato sulla logica e il razionale, sappiano essere così superficiali e irrazionali.
Il significato più ampio per definire il campo d'azione in cui tutte le pratiche si inscrivono è il termine "cosa", il latini dicevano quid o aliquid, il qualche cosa, i greci la cosa la definivano con i diversi termini pragma o crema; cosa deriva dal termine causa, ogni cosa é il prodotto di una causa (altra cosa).
La cosa i greci, tramite Platone nel libro Gamma de "La Repubblica", la definiscono come oscillante tra l'"essere" e il "niente" e la chiamano con il termine "ente", ciò che (= cosa) non è essere e non è niente ma cade sull'essere quando é e sul nulla quando non é, "caduca" appunto, come ogni cosa che oggi le filosofie moderne significano di ogni cosa diveniente.
Aristotele definisce il campo d'azione della scienza prima o filosofia nei termini di "ente in quanto ente" mentre per lo studio delle altre discipline scientifiche nei termini di "ente in quanto determinato".
Dice Aristotele che nessun'altra disciplina, come è della filosofia, si azzarda a sondare la natura dell'ente come universale ma si ferma a decifrarne gli aspetti particolari, come è della storia ad esempio, per questo motivo la filosofia é la scienza prima e é potenza.
Prendiamo ad esempio una sedia e un tavolo: per la scienza sono due determinazioni differenti con aspetti e funzioni particolari, la filosofia indaga sulla natura universale dei due oggetti, indaga sul "cosa" significano come cosa, cioè come ente in quanto ente e non in quanto determinato: se per le scienze i due oggetti si differenziano, per filosofia sono lo stesso in quanto enti e diverse in quanto determinate.
Tutto ciò che conosciamo è riducibile alla cosa, Dio è una cosa, io sono una cosa, l'iPad su cui scrivo è una cosa, il mercato europeo é una cosa, ecc..
Platone dice appunto che la cosa o ente oscilla tra l'essere e il suo opposto, il nulla, decidendone, dell'ente, la sorte degli ultimi secoli fino ai giorni nostri dell'occidente e per questo del mondo intero.
Ora, se l'ente nasce vive e muore (l'evolversi e lo spegnersi di Scalfari), non può esistere un energia eterna, in quanto questa "cosa" (Forma) violerebbe tale principio come la "cosa" eterna (Energia), contraddicendo "le cose" che nascono vivono e muoiono; se invece il principio degli enti come descritti da Platone è l'energia (=Dio) o ente eterno allora sono le "forme" come enti mortali (l'evolversi e lo spegnersi di Scalfari) che violano l'eternità dell'ente energia.
Aristotele fonda il principium firmassimum o principio di non contraddizione, che nella sua forma più semplice cita così: è impossibile che le cose siano e non siano al tempo stesso e nel medesimo riguardo.
Direi quindi che é impossibile che la "cosa" Energia sia eterna e la "cosa" Forma si generi dal nulla e torni nel nulla, con tutte le implicazioni del caso.
Questo Aristotele e Platone lo sapevano benissimo, mentre Scalfari sembra non curarsene, mostrando, in questo, di essere lui l'antico.
Post Scriptum
Nel libro, in un passo che segue, Scalfari cita così: "A me è capitato più volte di domandare ad amici ai quali mi legano simpatia, frequentazione, comunità di progetti e di lavoro: tu credi? Molto spesso la risposta è affermativa, ma se ancora domando: "in che cosa"? La risposta é appunto "in qualche cosa"".
Dru